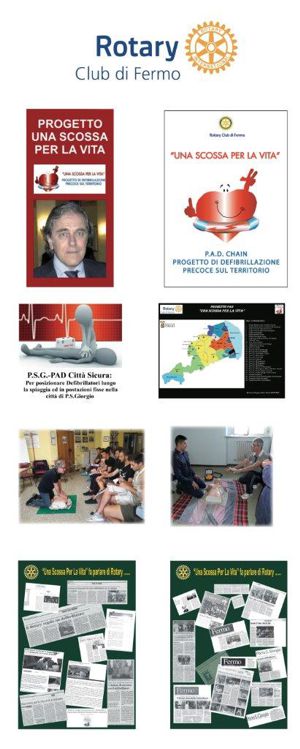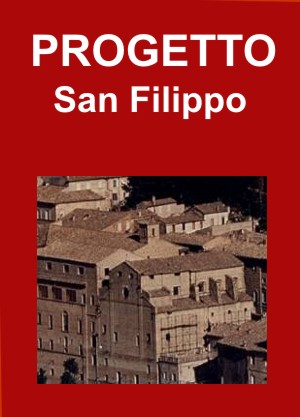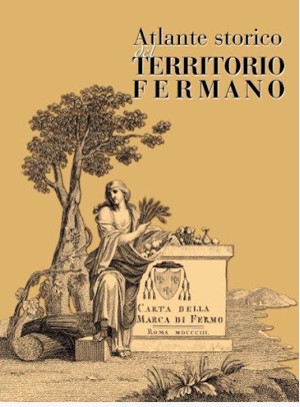In Spagna è molto facile licenziare, ma la disoccupazione supera il 20%. In Germania è invece piuttosto difficile ed i sindacati siedono nei Consigli di Vigilanza delle aziende del modello renano. Il tasso di disoccupazione tedesco è tuttavia sensibilmente inferiore a quello italiano. E’evidente che la facilità di licenziare non garantisce la piena occupazione.
Michael Porter, uno dei guru dell’economia d’impresa, nel suo magnifico Il vantaggio competitivo delle nazioni identificava nella difficoltà di licenziare uno dei fattori “selettivi” che inducono le imprese italiane ad investire in innovazione di medio-lungo periodo per aumentare la produttività. Il clima economico era quello, ancora effervescente, della fine degli anni ’80, mentre ora le prospettive sembrano molto diverse: la globalizzazione spinge a ripensare profondamente le filiere produttive piuttosto che ottimizzarle.
Nel ragionamento di Porter, tuttavia, si dispiega una verità da tenere sempre presente: le aziende che operano in settori ad alto contenuto di conoscenza o tecnologia hanno l’esigenza di conservare e qualificare nel tempo le loro risorse umane, molto di più di quella di potersene liberare a piacimento. L’economia della Germania è forte perché ha molte imprese di questo tipo. Non sorprende quindi che il suo sistema produttivo promuova il consenso con i lavoratori ed il sindacato.
Nei settori dove la competizione è maggiormente basata sui costi di una manodopera meno qualificata, la possibilità di un loro rapido aggiustamento può costituire un vantaggio competitivo. Ma questi sono i settori che in ogni caso la globalizzazione spinge fuori dai paesi avanzati.
Innumerevoli analisi ci dicono da tempo che l’economia italiana è debole sul primo versante, dove la competitività si costruisce anche motivando e attivando la spinta creativa dei lavoratori piuttosto che terrorizzandoli con la paura di perdere il lavoro.
Ma è proprio così difficile licenziare in Italia?
Chiudere un’azienda, o ridimensionarla, non è mai stato un grosso problema da noi. E’ più difficile in Francia ed in molti casi negli Stati Uniti. Gli accordi tra sindacati e Confindustria e la legge del 1991 sui licenziamenti collettivi prevedono solo procedure conciliative e non vincolanti, svolte le quali l’imprenditore è libero di licenziare.
Il totemico articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che impone il reintegro del lavoratore licenziato senza giusta causa (cioè per colpa) o giustificato motivo (cioè per esigenze organizzative dell’impresa) si applica a non più del 25% dei lavoratori dipendenti italiani. Questa percentuale è in calo da decenni insieme con la dimensione media delle aziende. Quando nasce un conflitto, nel 93% dei casi la causa si conclude con l’allontanamento del lavoratore ed il pagamento di un’indennità. Qual è il problema allora? A meno che non si sostenga che mettere uno in mezzo alla strada senza una ragione fondata sia bello, specie in Italia, dove la rete di protezione per i disoccupati è tra le meno generose in Europa.
La legislazione sui contratti di lavoro atipici, inoltre, ha dotato da tempo le imprese (e gli enti pubblici) italiani di strumenti legali per creare il loro “esercito industriale di riserva” e uno strato di precariato (in gran parte giovanile) in grado di assorbire quasi immediatamente le oscillazioni della domanda.
Ma allora può essere che il problema sia diverso: si sta creando una frattura tra lavoratori decentemente protetti dall’arbitrio e una massa di senza speranza che perde progressivamente anche la motivazione a costruirsi non solo una “carriera” ma anche un percorso professionale di arricchimento nel tempo delle proprie competenze, cioè proprio quello di cui una moderna economia post-industriale ha bisogno.
Gli studiosi più attenti di diritto del lavoro, come Pietro Ichino, propongono una revisione complessiva del sistema delle relazioni industriali che semplifichi l’adeguamento organizzativo delle aziende, vincolandole allo stesso tempo ad assumersi la responsabilità della formazione dei dipendenti (in caso di spostamento a diverse mansioni) o del loro ricollocamento in caso di dismissione. In questa direzione si colloca l’idea di un contratto unico di lavoro che riduca l’area del precariato ai casi dove esso ha maggiormente senso (lavori a progetto, apprendistato per i giovani), ricomponendo una frattura sociale che si va pericolosamente allargando (si pensi agli indignados). Alla riforma contrattuale si deve affiancare il sostegno pubblico nella fase di ricollocazione dei lavoratori in esubero, con adeguate tutele economiche ed incentivi alla riqualificazione professionale.
Questa prospettiva richiede pensiero e capacità di governo del sistema, da parte della politica e delle forze sociali, non slogan. Pensare di polverizzare il diritto del lavoro affidandolo ad accordi aziendali (il famoso art. 8 della manovra estiva) senza un quadro di riferimento nazionale rischia di alimentare ulteriormente una giungla dei diritti dove risentimento e confusione regnano sovrane.
Ma il coraggio delle riforme serie questo Paese ce l’ha?
Luca Romanelli – www.lucaromanelli.it
Categoria | "Res Publica" di Luca Romanelli, In Rilievo, RUBRICHE
2011.11.10 – Licenziamenti facili e crescita economica di Luca Romanelli
Pubblicato il 10 Novembre 2011 da admin

-
CATEGORIE
- "Accade a Fermo" di Angelica Malvatani (96)
- "Altra chiave" (9)
- "Approfondimenti" di Gennaro Avano (5)
- "Appunti di viaggio" di Giuseppe Amici (1)
- "Atlante storico del Territorio Fermano" di Tommaso Fattenotte (6)
- "Consumo zero nei nostri manufatti" di Stefania Bellabarba (5)
- "Dedicato a te" di Marzia Marchionni (14)
- "Economia e finanza" di Marchetto Morrone Mozzi (27)
- "Il Fermano terra della della Ricerca" di Giovanni Martinelli (11)
- "Il Fermano terra della musica" di Giovanni Martinelli (11)
- "Il Fermano terra di artisti" di Giovanni Martinelli (10)
- "Il Fermano terra di Condottieri" di Giovanni Martinelli (9)
- "Il Fermano terra di eroi" di Giovanni Martinelli (5)
- "Il Fermano terra di letterati" di Giovanni Martinelli (11)
- "Il Fermano terra di politici" di Giovanni Martinelli (11)
- "Il Fermano terra di santi" di Giovanni Martinelli (11)
- "Il Fermano: I protagonisti della Grande Guerra" di Giovanni Martinelli (1)
- "Il notaio consiglia" di Alfonso Rossi (60)
- "Il punto sulla ricerca" di Alessandra Pompei (52)
- "Il Rotary e i valori etici delle Professioni e della Scienza" di Alberto Breccia Fratadocchi (7)
- "L'arte spiegata" di Gennaro Natale (12)
- "L'istruzione professionale" di Stefania Scatasta (3)
- "L'odontoiatria" di Leila Makki (6)
- "La chimica al Montani" di Teresa Cecchi (9)
- "La informatizzazione del Distretto" di Tommaso Fattenotte (11)
- "La storia del Club" di Tommaso Fattenotte (20)
- "Liberalizzazioni" di Alessandra Pompei (1)
- "Liberalizzazioni" di Alfonso Rossi (1)
- "Lo sviluppo del fermano – Potenzialità e strategie" di Paolo Appoggetti (1)
- "Notizie Polari" di Maria Pia Casarini (3)
- "Oto-Rotary" di Simonetta Calamita (47)
- "Pazienti illustri della nostra storia" di Paolo Signore (12)
- "Pazienti illustri" di Paolo Signore (5)
- "Pazienti, utenti e cittadini" di Sivana Zummo (2)
- "Pianificazione del territorio" di Giulia Catani (7)
- "Protezione civile" di Serenella Ciarrocchi (4)
- "Recensioni film" di Alfonso Rossi (27)
- "Res Publica" di Luca Romanelli (70)
- "Ricordi" di Fabrizio Emiliani (5)
- "Riordino delle Province" (186)
- "Risorgimento nel fermano" di Giovanni Martinelli (4)
- "Senso civico" di Alberto Valentini (1)
- "Spigolature" di Gennaro Natale (5)
- "Voci dalla scuola" di Margherita Bonanni (22)
- 150° (8)
- 2001-2002 (10)
- 2002-2003 (11)
- 2003-2004 (11)
- 2004-2005 (12)
- 2005-2006 (15)
- 2006-2007 (9)
- 2007-2008 (13)
- 2008-2009 (12)
- 2009-2010 (19)
- 2010-2011 (9)
- 2011-2012 (12)
- 2012-2013 (14)
- 2013-2014 (13)
- 2014-2015 (12)
- 2015-2016 (12)
- 2016 – 2017 (23)
- 2017-2018 (12)
- 2018-2019 (11)
- 2019-2020 (11)
- 2020 – 2021 (12)
- 2021-2022 (12)
- 2022-2023 (9)
- 2023-2024 (6)
- 50° (38)
- Accademia Organistica Elpidiense (12)
- AIDO (19)
- Alberto Breccia Fratadocchi (2)
- Alberto Pazzi (2)
- Ambulatorio Ortopedico ad Amandola e Comunanza (1)
- Anni 1960-1969 (5)
- Anni 1970-1979 (7)
- Anni 1980-1989 (13)
- Anni 1990-1999 (22)
- Archivio fotografico (12)
- Archivio fotografico (376)
- Auto medica (2)
- Banco alimentare (1)
- Bus-medico (1)
- Carlo Cacciatori (1)
- Certamen latinum firmanum (1)
- Cestoni (2)
- Comunicazioni (105)
- Conservatorio di Fermo (2)
- Convegni (13)
- Convegni (4)
- Convention (1)
- Cos'è il Rotaract (1)
- Costantino Strappa (1)
- Cuore di bimbi (9)
- Dai Club Rotaract (10)
- dai soci (5)
- Dalle Commissioni (9)
- Daniela Diletti (7)
- Di Med (12)
- Distretto 2090 (100)
- Dove siamo (1)
- DVD – I 40 Comuni (2)
- Edoardo Antuono (2)
- Eventi (14)
- Eventi del mese (16)
- Fabio D'Erasmo (1)
- FAI Fermo (14)
- Fenice (38)
- Forum (3)
- Forum Distrettuali (11)
- Giulia Catani (5)
- Giuseppe Amici (2)
- I consigli dell' Odontoiatra di Andrea Giammarini (3)
- I Presidenti (1)
- I Soci del Club (1)
- I soci fondatori (1)
- Idea Enterprise (17)
- Idea Interprice (1)
- Il Club (10)
- Il Club (2)
- Il Collegio dei Past President (2)
- Il cuore dei bambini (11)
- Il filo di Arianna (4)
- Il giardino delle meraviglie (2)
- Il Ponte (8)
- Il programma (1)
- In Rilievo (654)
- Iniziative dei soci (44)
- Inner Wheel (23)
- Interact Fermo (1)
- Invecchiare in salute: quali percorsi? (5)
- Italo Gaudenzi (1)
- La biblioteca nel carrello (7)
- La carta e le segnalazioni (6)
- La città di Fermo – foto (1)
- La Città e la Provincia di Fermo – filmati (1)
- La storia (1)
- La storia del Club (50)
- Leopardi (1)
- Lettere del Presidente (18)
- Lettere Governatore (66)
- Lettere mensili (288)
- Mappe antiche (3)
- Mare per tutti (3)
- Mary Leoni (6)
- Massimo Maccari (1)
- Minibus (1)
- New (455)
- Norberto Dionisi (8)
- Notizie dai Club (50)
- Operazione sorriso (6)
- Organigramma (1)
- Paola Campanella (2)
- Paolo Appoggetti (6)
- Paul Harris (2)
- Piciotti Giampaolo (1)
- Pio Carlini (1)
- PROGETTI (429)
- Progetto "Rotary gardens" (4)
- Progetto prefabbricati per i terremotati (10)
- Progetto salute "I love my voice" (21)
- Progetto Salute – Roncopatia (6)
- Progetto salute: a scuola di salute orale (1)
- Pubblicazioni (12)
- Pubblicazioni (23)
- R.I. (35)
- Rassegna stampa (2)
- Restauri (7)
- Restauro Chiesa San Filippo Neri (15)
- Riordino delle Province (8)
- Rotaract (76)
- Rotaryfermo Channel (109)
- RUBRICHE (722)
- screening elettrocardiografico (3)
- Scuole (20)
- Sentirsi bene a scuola (1)
- Sitting volley (6)
- Solidarietà (2)
- Statuto e Regolamento (1)
- Storia (2)
- Terremoto Abruzzo (5)
- Trofeo Rotary Fermo (73)
- Una scossa per la vita (61)
- Videoconferenze (5)
- WEB-TV (10)
-
EVENTI
« Ott 
Dic » Novembre 2011 L M M G V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
-
ARCHIVI
- Febbraio 2024 (1)
- Gennaio 2024 (2)
- Dicembre 2023 (5)
- Novembre 2023 (5)
- Ottobre 2023 (2)
- Settembre 2023 (3)
- Luglio 2023 (9)
- Maggio 2023 (2)
- Aprile 2023 (1)
- Marzo 2023 (1)
- Febbraio 2023 (3)
- Gennaio 2023 (2)
- Dicembre 2022 (2)
- Novembre 2022 (7)
- Ottobre 2022 (4)
- Settembre 2022 (1)
- Agosto 2022 (2)
- Luglio 2022 (4)
- Giugno 2022 (3)
- Maggio 2022 (3)
- Aprile 2022 (3)
- Marzo 2022 (4)
- Febbraio 2022 (1)
- Gennaio 2022 (1)
- Dicembre 2021 (5)
- Novembre 2021 (1)
- Ottobre 2021 (1)
- Settembre 2021 (3)
- Agosto 2021 (1)
- Luglio 2021 (6)
- Giugno 2021 (6)
- Maggio 2021 (5)
- Aprile 2021 (3)
- Marzo 2021 (1)
- Febbraio 2021 (5)
- Gennaio 2021 (1)
- Dicembre 2020 (5)
- Novembre 2020 (10)
- Ottobre 2020 (9)
- Settembre 2020 (3)
- Agosto 2020 (9)
- Luglio 2020 (2)
- Giugno 2020 (4)
- Maggio 2020 (9)
- Aprile 2020 (11)
- Marzo 2020 (16)
- Febbraio 2020 (7)
- Gennaio 2020 (9)
- Dicembre 2019 (5)
- Novembre 2019 (4)
- Ottobre 2019 (2)
- Settembre 2019 (9)
- Agosto 2019 (2)
- Luglio 2019 (6)
- Giugno 2019 (4)
- Maggio 2019 (8)
- Aprile 2019 (8)
- Marzo 2019 (28)
- Febbraio 2019 (9)
- Gennaio 2019 (13)
- Dicembre 2018 (14)
- Novembre 2018 (15)
- Ottobre 2018 (10)
- Settembre 2018 (5)
- Agosto 2018 (4)
- Luglio 2018 (13)
- Giugno 2018 (11)
- Maggio 2018 (31)
- Aprile 2018 (15)
- Marzo 2018 (10)
- Febbraio 2018 (13)
- Gennaio 2018 (24)
- Dicembre 2017 (11)
- Novembre 2017 (20)
- Ottobre 2017 (13)
- Settembre 2017 (23)
- Agosto 2017 (7)
- Luglio 2017 (12)
- Giugno 2017 (11)
- Maggio 2017 (17)
- Aprile 2017 (12)
- Marzo 2017 (9)
- Febbraio 2017 (4)
- Gennaio 2017 (10)
- Dicembre 2016 (10)
- Novembre 2016 (27)
- Ottobre 2016 (18)
- Settembre 2016 (21)
- Agosto 2016 (10)
- Luglio 2016 (16)
- Giugno 2016 (10)
- Maggio 2016 (17)
- Aprile 2016 (13)
- Marzo 2016 (16)
- Febbraio 2016 (15)
- Gennaio 2016 (12)
- Dicembre 2015 (17)
- Novembre 2015 (23)
- Ottobre 2015 (19)
- Settembre 2015 (13)
- Agosto 2015 (7)
- Luglio 2015 (13)
- Giugno 2015 (12)
- Maggio 2015 (19)
- Aprile 2015 (6)
- Marzo 2015 (15)
- Febbraio 2015 (19)
- Gennaio 2015 (14)
- Dicembre 2014 (17)
- Novembre 2014 (15)
- Ottobre 2014 (9)
- Settembre 2014 (11)
- Agosto 2014 (11)
- Luglio 2014 (15)
- Giugno 2014 (12)
- Maggio 2014 (15)
- Aprile 2014 (12)
- Marzo 2014 (10)
- Febbraio 2014 (22)
- Gennaio 2014 (14)
- Dicembre 2013 (19)
- Novembre 2013 (17)
- Ottobre 2013 (23)
- Settembre 2013 (19)
- Agosto 2013 (27)
- Luglio 2013 (13)
- Giugno 2013 (25)
- Maggio 2013 (25)
- Aprile 2013 (36)
- Marzo 2013 (29)
- Febbraio 2013 (22)
- Gennaio 2013 (16)
- Dicembre 2012 (23)
- Novembre 2012 (16)
- Ottobre 2012 (69)
- Settembre 2012 (81)
- Agosto 2012 (95)
- Luglio 2012 (32)
- Giugno 2012 (16)
- Maggio 2012 (15)
- Aprile 2012 (14)
- Marzo 2012 (24)
- Febbraio 2012 (22)
- Gennaio 2012 (23)
- Dicembre 2011 (21)
- Novembre 2011 (28)
- Ottobre 2011 (26)
- Settembre 2011 (23)
- Agosto 2011 (22)
- Luglio 2011 (19)
- Giugno 2011 (51)
- Maggio 2011 (53)
- Aprile 2011 (46)
- Marzo 2011 (45)
- Febbraio 2011 (24)
- Gennaio 2011 (16)
- Dicembre 2010 (10)
- Novembre 2010 (14)
- Ottobre 2010 (6)
- Settembre 2010 (13)
- Agosto 2010 (10)
- Luglio 2010 (12)
- Giugno 2010 (14)
- Maggio 2010 (8)
- Aprile 2010 (22)
- Marzo 2010 (20)
- Febbraio 2010 (19)
- Gennaio 2010 (15)
- Dicembre 2009 (20)
- Novembre 2009 (19)
- Ottobre 2009 (16)
- Settembre 2009 (18)
- Agosto 2009 (14)
- Luglio 2009 (25)
- Giugno 2009 (19)
- Maggio 2009 (16)
- Aprile 2009 (10)
- Marzo 2009 (6)
- Febbraio 2009 (2)
- Gennaio 2009 (2)
- Dicembre 2008 (5)
- Novembre 2008 (2)
- Ottobre 2008 (4)
- Settembre 2008 (2)
- Agosto 2008 (2)
- Luglio 2008 (5)
- Giugno 2008 (9)
- Maggio 2008 (11)
- Aprile 2008 (5)
- Marzo 2008 (3)
- Febbraio 2008 (5)
- Gennaio 2008 (5)
- Dicembre 2007 (3)
- Novembre 2007 (3)
- Ottobre 2007 (2)
- Settembre 2007 (5)
- Agosto 2007 (2)
- Luglio 2007 (5)
- Giugno 2007 (2)
- Maggio 2007 (5)
- Aprile 2007 (1)
- Marzo 2007 (2)
- Febbraio 2007 (1)
- Gennaio 2007 (2)
- Dicembre 2006 (2)
- Novembre 2006 (1)
- Settembre 2006 (1)
- Agosto 2006 (1)
- Luglio 2006 (1)
- Giugno 2006 (4)
- Maggio 2006 (2)
- Aprile 2006 (4)
- Marzo 2006 (4)
- Febbraio 2006 (3)
- Gennaio 2006 (3)
- Dicembre 2005 (3)
- Novembre 2005 (4)
- Ottobre 2005 (1)
- Settembre 2005 (2)
- Agosto 2005 (1)
- Luglio 2005 (5)
- Giugno 2005 (6)
- Maggio 2005 (2)
- Aprile 2005 (3)
- Marzo 2005 (1)
- Febbraio 2005 (1)
- Gennaio 2005 (3)
- Dicembre 2004 (1)
- Novembre 2004 (1)
- Ottobre 2004 (1)
- Settembre 2004 (2)
- Agosto 2004 (1)
- Luglio 2004 (2)
- Giugno 2004 (2)
- Maggio 2004 (1)
- Aprile 2004 (2)
- Marzo 2004 (2)
- Febbraio 2004 (1)
- Gennaio 2004 (2)
- Dicembre 2003 (1)
- Novembre 2003 (1)
- Ottobre 2003 (1)
- Settembre 2003 (1)
- Agosto 2003 (2)
- Luglio 2003 (2)
- Giugno 2003 (4)
- Maggio 2003 (3)
- Aprile 2003 (1)
- Marzo 2003 (2)
- Febbraio 2003 (1)
- Gennaio 2003 (2)
- Dicembre 2002 (2)
- Novembre 2002 (1)
- Ottobre 2002 (1)
- Settembre 2002 (1)
- Agosto 2002 (2)
- Luglio 2002 (2)
- Giugno 2002 (1)
- Aprile 2002 (2)
- Marzo 2002 (1)
- Febbraio 2002 (1)
- Dicembre 2001 (1)
- Novembre 2001 (1)
- Ottobre 2001 (1)
- Settembre 2001 (1)
- Luglio 2001 (2)
- Giugno 2001 (1)
- Maggio 2001 (1)
- Aprile 2001 (2)
- Marzo 2001 (1)
- Febbraio 2001 (1)
- Gennaio 2001 (1)
- Dicembre 2000 (1)
- Novembre 2000 (1)
- Ottobre 2000 (2)
- Settembre 2000 (1)
- Agosto 2000 (1)
- Luglio 2000 (3)
- Giugno 2000 (2)
- Maggio 2000 (2)
- Aprile 2000 (2)
- Marzo 2000 (3)
- Febbraio 2000 (2)
- Gennaio 2000 (1)
- Dicembre 1999 (2)
- Novembre 1999 (1)
- Ottobre 1999 (3)
- Settembre 1999 (3)
- Agosto 1999 (2)
- Luglio 1999 (3)
- Luglio 1998 (1)
- Luglio 1997 (1)
- Luglio 1996 (1)
- Luglio 1995 (1)
- Luglio 1994 (1)
- Luglio 1993 (1)
- Luglio 1992 (2)
- Giugno 1992 (1)
- Maggio 1992 (1)
- Aprile 1992 (1)
- Marzo 1992 (1)
- Febbraio 1992 (1)
- Gennaio 1992 (1)
- Novembre 1991 (1)
- Ottobre 1991 (1)
- Settembre 1991 (1)
- Agosto 1991 (1)
- Luglio 1991 (2)
- Aprile 1991 (1)
- Luglio 1990 (1)
- Luglio 1989 (1)
- Aprile 1989 (1)
- Luglio 1988 (1)
- Luglio 1987 (1)
- Luglio 1986 (1)
- Luglio 1985 (1)
- Luglio 1984 (1)
- Luglio 1983 (1)
- Luglio 1982 (1)
- Luglio 1980 (1)
- Luglio 1978 (1)
- Giugno 1977 (1)
- Luglio 1976 (1)
- Aprile 1976 (1)
- Luglio 1975 (1)
- Luglio 1973 (1)
- Luglio 1971 (1)
- Luglio 1969 (1)
- Luglio 1968 (1)
- Luglio 1966 (1)
- Luglio 1964 (1)
- Luglio 1962 (1)
- Marzo 1961 (1)
- Aprile 1960 (1)
- 0 (1)