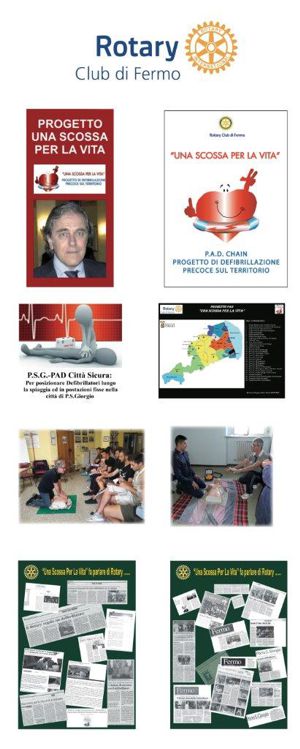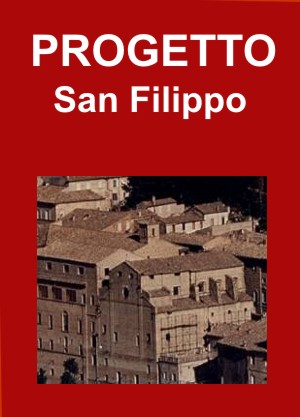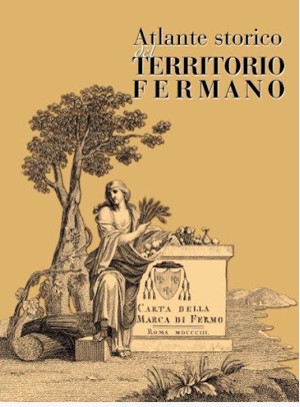Se ci s’interroga sugli effetti della globalizzazione, c’è una sola certezza: la globalizzazione è un processo estremamente complesso i cui effetti sono difficili sia da stimare sia da interpretare.
Nessun fenomeno può definirsi giusto o sbagliato a prescindere, tanto più se si tratta di un fenomeno complesso intriso di minacce e di opportunità.
Governare il processo della globalizzazione passa inevitabilmente per dei cambiamenti culturali che sono strutturali. La capacità di aprirsi ai mercati è la sfida che ogni Stato, e di conseguenza ogni Territorio, ha davanti a sé, pena l’esserne travolto.
Le principali minacce da affrontare sono rappresentate dall’aumento delle disuguaglianze e delle turbolenze finanziarie, dai flussi migratori (tema attualissimo) e dalle instabilità geopolitiche, dall’eventuale insostenibilità del processo e dal Brain Drain.
Le opportunità da cogliere riguardano tassi di crescita più alti, flussi migratori (tipico esempio di Giano Bifronte), riduzione dei prezzi per il consumatore e possibilità di poter accedere a maggiori investimenti diretti esteri.
Nel recente passato, la maggior parte dei Paesi aveva aderito al processo accettandone, più o meno consapevolmente, minacce e opportunità. Questo slancio è stato figlio della visione mainstream secondo cui i Paesi con un maggiore grado di apertura commerciale sono anche quelli che registrano sia maggiori tassi di crescita sia maggiori benefici per i consumatori.
Tuttavia, questa luna di miele sembra essere terminata. Attualmente, lo scenario mondiale sembra essersi frammentato e nella frammentazione dominano proposte nazionaliste spinte da una crescente richiesta di protezione. Dieci anni di crisi, hanno lasciato cicatrici profonde nel tessuto delle Società Occidentali, e la più profonda di tutte sembra essere la Paura.
Una Paura, forse inascoltata, che negli anni ha finito per diventare rabbia. Una rabbia che, a sua volta, alimentandosi della stessa paura che l’ha generata, innesca una spirale viziosa pericolosissima.
Gli individui nelle Società Occidentali sembrano aver paura di non farcela. Si ha paura che il futuro sia peggiore del presente e del passato, si ha paura del prossimo, una paura che diventa per giunta terrore se il prossimo è diverso, si ha paura di un confine che non è più tale, si ha paura di ciò che non si conosce e che, ahimè, non si ha più la voglia di conoscere. Insomma si prova una paura che è figlia della perdita di fiducia in sé stessi. Una perdita di fiducia che induce ogni individuo a tentare di costruirsi quale proprio capro espiatorio, un nemico su misura, preferibilmente debole, e presumibilmente facile sia da combattere sia da sconfiggere.
Tuttavia, per chi crede che non ci si debba consegnare alla paura vi è sempre una terza via. Una via che necessariamente passa per l’essere d'ispirazione. Infatti, non aver paura del futuro, del diverso, del prossimo, significa aver fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità di costruire il futuro, il che non significa
volersi aprire al mondo in maniera scriteriata. In altri termini, non aver paura, ad esempio, significa avere il coraggio e l’ambizione di voler governare i flussi migratori. Regolare i flussi significa dare massima priorità alla domanda di sicurezza dei Cittadini, cercando di stringere accordi multilaterali frutto della cooperazione internazionale, significa passare da una visione in cui la priorità si sposta dall’accoglienza all’integrazione, consci del fatto che nessun Cittadino debba vivere nella paura, sentendosi insicuro, solo, abbandonato o peggio ancora minacciato. C’è un tema di percezione della realtà che va governato. La guerra tra poveri può essere disinnescata offrendo ai Cittadini delle soluzioni che siano capaci di rispondere adeguatamente al loro bisogno di Sicurezza. Il tema della Sicurezza, peraltro, non può diventare mera merce di una permanente campagna elettorale. La Sicurezza è un diritto dell’essere umano in quanto tale e uno Stato civile deve essere in grado di garantirla a prescindere dal consenso dei Cittadini.
Tornando ad un quadro più squisitamente economico, globalizzare significa andare ad esplorare nuovi mercati, imparare nuove lingue, utilizzare nuovi strumenti, innovare, digitalizzare. Globalizzare in una sola parola significa essere Glocal ed essere Glocal, vuol dire valorizzare le eccellenze locali cogliendo le opportunità del mercato mondiale. Avere una visione Glocal significa abbattere muri che arrecano danni reciproci per costruire ponti che permettano di ottenere vantaggi reciproci.
La globalizzazione però non può ridursi ad essere un atto di fede, né tantomeno una guerra di religione. La globalizzazione deve essere una scelta consapevole presa a valle di un processo di approfondimento che abbia visto i Cittadini protagonisti.
La letteratura ci ricorda che nel medio periodo sia le imprese sia le famiglie sono in grado di ottenere dei vantaggi dal processo di globalizzazione, e pertanto ogni spinta di natura protezionista rischia di produrre dei danni. Danni, che un Paese esportatore come l’Italia, ma anche un Territorio come quello fermano, molto vocato all’internazionalizzazione, non possono permettersi.
Infine, in quest’epoca in cui approfondire sembrerebbe non essere più di moda, in cui tutti sembrano essere alla ricerca compulsiva di facili certezze cui consegnare la propria rabbia è indispensabile riesumare il buon caro vecchio dubbio inteso come metodo.
Quindi, più che con delle certezze vorrei terminare tentando di insinuare un dubbio: nell’epoca del “World Wide Web” (rete di grandezza mondiale) e “dell’Effetto farfalla”, ha ancora senso parlare di ponti e di muri o si corre semplicemente il rischio di essere anacronistici?
Fabio D’Erasmo