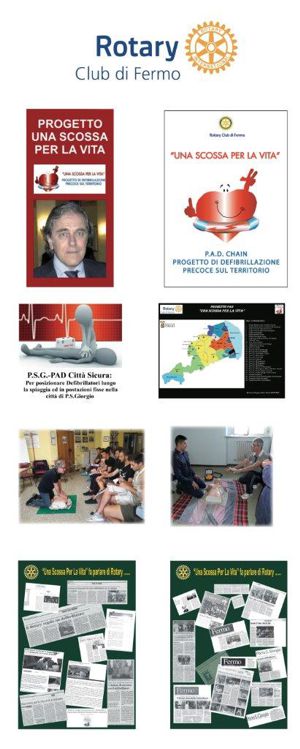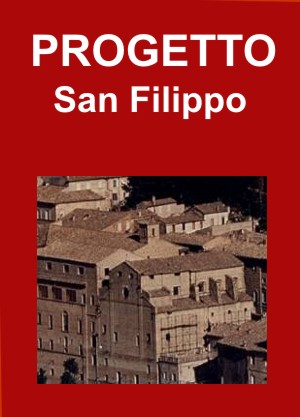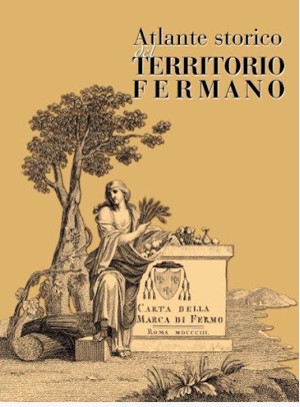"Al conte Giacomo Leopardi, recanatese, filologo, ammirato fuori d'Italia, scrittore di filosofia e di poesie altissimo da paragonare soltanto coi greci, che finì di XXXIX anni la vita per continue malattie miserissima. Antonio Ranieri fece all'amico adorato”. MDCCCXXXVII
Questa l'iscrizione sulla lapide a memoria di Giacomo Leopardi fatta porre dall'amico Antonio Ranieri a Napoli nella chiesa di San Vitale a Fuorigrotta, colà avventurosamente sepolto all'alba del 16 Giugno 1837. Il genio di Recanati infatti morì a Napoli, all’età di 39 anni, dopo una vita tormentata da gravi malattie ed immani sofferenze. Il 21 luglio 1900, alla presenza dei rappresentanti del Re e del Comune di Napoli, fu aperto il sepolcro del poeta recanatese e dal rapporto necroscopico redatto dal dottor Zuccarelli risultarono mancanti le ossa del cranio e della faccia, mentre erano presenti residui di costole e del tarso, le ossa del femore sinistro ed alcune vertebre tra cui quelle, deformate, del torace: fatte le debite misurazioni paleopatologiche, Leopardi risultava così non più alto di 1,40/1,45 metri, con una forte sproporzione del tronco rispetto al resto del corpo, non superando lo stesso il mezzo metro d’altezza. Ma la particolarità che colpì la Commissione Ministeriale fu la deformità del rachide cervico-dorsale e dello sterno, perfettamente in linea con quanto descritto all’epoca dal Dr. Cioni, medico curante ed amico della famiglia Leopardi, che accompagnò il poeta in un viaggio a Firenze e Pisa: “Esile, pallido, gobbo avanti e dietro, parea un tisico”. Lo stesso Leopardi descrive la sua gobba come “un baule, pesante e greve, che mi porto sulle spalle”, una gravissima deformità sicuramente non presente nel nostro illustre paziente in età giovanile, che compare dopo i 13/14 anni come testimoniato dal Marchese Solari di Loreto che scrive testualmente: “L’ho lasciato sano e dritto, lo trovo dopo cinque anni consunto e scontorto, con avanti e dietro qualcosa di veramente orribile”.
Al pari di Mozart con suo padre Leopold, Giacomo è un bambino prodigio che cresce sotto lo sguardo orgoglioso ed implacabile del padre, il conte Monaldo, uomo meschino e gretto, in una casa che è una biblioteca, in cui la mente infinita di Giacomo cerca spazio, impara tutto e tutto padroneggia, in una prigione da cui non esce mai, dove l’universo è fuori, lontano, irraggiungibile. Il poeta si immola così in quelli che lui stesso definirà “sette anni di studi pazzi e disperatissimi”, si butta in modo quasi ossessivo sui testi classici e sulle lingue antiche (greco, latino ed aramaico) e moderne (francese, spagnolo ed ebraico). Studia per ore ed ore curvo sui libri in tutte le posizioni, anche disteso a terra alla luce di un lumino e tutto ciò non fa certamente bene alla sua salute, in una postura viziata e malsana, non consona alla malattia che inesorabilmente sta aggredendo le sue ossa, in particolare lo sterno e le vertebre, con la conseguenza di un irreparabile danno morfologico: una gobba avanti e dietro, un connotato leggendario nato nel "natio borgo selvaggio". "Gobbus esto / Fammi un canestro / Fammelo cupo / Gobbo fottuto": questa, secondo le biografie, la filastrocca con cui lo canzonavano i compaesani al suo passaggio. E la causa di tutto ciò fu la Tubercolosi ed in particolare la variante ossea, quel “Morbo di Pott” che deformò in modo irreversibile la sua schiena ed il torace. Di tubercolosi, peraltro, morirono lo zio paterno e suo fratello Luigi e lo stesso Giacomo nella Cantica “L’appressamento della morte” descrive dettagliatamente il suo stato di malessere (“...frequenti mi occorrono febbri maligne, catarri e sputi di sangue...”), in perfetta linea con i sintomi tipici della malattia stessa. Tutte queste considerazioni fanno ragionevolmente apparire infondate le ipotesi avanzate da alcuni studiosi che la deformità toracica del “Magnifico Poeta” potesse essere causata da una Cifosi Congenita o da una semplice forma di Rachitismo, quale frutto di uno stile di vita e di un’alimentazione non adeguata.
Dall’età di vent’anni e fino alla morte Leopardi soffrì anche di una grave forma di Oftalmia ad andamento cronico con periodi di dolorose riacutizzazioni che lo costringevano a fuggire da luoghi illuminati ed a muoversi e lavorare soltanto nelle ore crepuscolari e notturne (“...miseramente obbligato sono ad una vita da gufo...”). Numerosi oculisti si sono occupati della natura di questa malattia ipotizzando quella che, sulla base dell’interpretazione in vero dubbia di alcuni passi dell’Epistolario, potesse trattarsi genericamente di miopia, ma che sembra essere piuttosto una Presbiopia o Ipermetropia, se si considera che glii scritti del poeta fanno frequente riferimento ad oggetti e visioni particolari che il miope non può assolutamente descrivere se osservati da lontano. A causa di questa infermità, non poteva applicarsi se non per brevi periodi di tempo alla lettura ed ancor meno alla scrittura, a costo di intensi dolori agli occhi ed al capo. La malattia oculare, alterando la facoltà visiva sino ad abolirla quasi totalmente, costituì il suo tormento maggiore, fisico e morale al contempo: privato dello studio, condannato a consumare la giornata seduto a braccia conserte giungeva a dire "...sono un tronco che non vede, sente e pena...".
Un’altro male si presentò quando il poeta aveva vent'anni circa, quel "mal di visceri" secondo le parole di Giacomo stesso, motivo di sofferenze intestinali caratterizzate da stipsi, diarrea e dolori addominali, una triade sintomatologica tipica dell’ Enterocolite Mucomembranosa. Tale sintomatologia si accentuava durante i viaggi, predominava sugli altri malanni e sicuramente non giovavano alle già compromesse funzioni intestinali la vita irregolare (Leopardi era solito studiare e scrivere di notte, dormire di giorno e pranzare nel tardo pomeriggio), l'abuso di caffè e soprattutto l’eccessiva golosità per i dolciumi.
In questo periodo inoltre i suoi malanni diventano l’inevitabile causa di una “…profonda prostrazione d’animo…”, uno stato di grave Depressione quale impatto psicologico della malattia fisica, quella proverbiale, feconda malinconia senza la quale non avrebbe toccato le vette sublimi di vena poetica che ben conosciamo. Per anni se ne sono occupati medici, psicologi, psichiatri e psicanalisti e fu per questo variamente definito un abulico, insicuro, asociale, disordinato, uno psicopatico combattuto dalla follia degli scrupoli, dalle allucinazioni, dall’idea fissa del suicidio. Ma quei frequenti cambi di umore nel corso della sua vita, con bruschi passaggi dall’euforia più totale alla disperazione inconsolabile, dall’esplosione di desideri incontenibili all’accidia causata dal disagio sociale, dalla sua innata timidezza, dalla consapevolezza “…dell’esistenza come dolore…” hanno fatto, non a torto, ipotizzare che Leopardi fosse affetto da un Disturbo Psicotico Bipolare, condizione questa che rese certamente ancor più acuto il suo disagio sociale, costringendo il poeta ad una condizione di inferiorità e sudditanza nei confronti di tutto ciò che lo circondava.
Ma Leopardi, esasperato dall’ambiente familiare e dalla chiusura culturale delle Marche governate all’epoca dal retrivo Stato Pontificio, ebbe la forza di reagire e cercò anche di fuggire da casa, un goffo tentativo rapidamente represso dal padre che, però, nulla poté qualche anno dopo quando Giacomo, grazie ad una sufficiente indipendenza economica, all’avvio di una fattiva collaborazione con l’editore milanese Stella ed alla duratura amicizia con Antonio Ranieri cominciò a girare per l’Italia: Milano, Bologna, Roma e Firenze furono le sue tappe obbligate, ma Napoli l’ultima, dove il 14 Giugno 1837 terminò la sua vita breve e sofferta, mentre in città imperversava una devastante epidemia di colera.
Sulla morte del poeta di Recanati le ipotesi non sono mai mancate, anche le meno verosimili: dalle conseguenze del colera come sostenuto da alcuni studiosi, all’eccessiva ingestione di confetti di Sulmona portati in dono dalla sorella Paolina, dall'indigestione a causa della somministrazione di una tazza di brodo caldo di pollo seguita da una limonata fredda, all’idropsia come dichiarato dallo stesso Antonio Ranieri nella cui abitazione il poeta terminò la sua esistenza. Il soggiorno napoletano fu artisticamente fertile per Leopardi e buono inizialmente il rapporto con la città ed i suoi abitanti, ma ben presto qualcosa cambia: l’aggravarsi della perdita dell’acuità visiva e delle condizioni respiratorie costringono il poeta al costante isolamento in un rapporto di conflittualità crescente con il mondo che lo circonda (“… sento il bisogno di fuggire da questo paese veramente barbaro, lazzaroni e pulcinelli, nobili e plebei, tutti ladri ...”). La deformità del torace con costrizione degli organi al suo interno accentua sempre più la sindrome restrittiva polmonare, la tosse si fa con “spurghi di sangue”, i dolori toracici (“assalti di petto”) sempre più frequenti e si aggrava la difficoltà alla respirazione ("… l’asma m'impedisce il camminare, il giacere e il dormire, soffoco, Antonio, fammi vedere la luce…"): il Cuore Polmonare Cronico, inevitabilmente instauratosi in questi anni a causa delle gravi deformità toraciche, evolve rapidamente verso un irreversibile quadro di insufficienza cardio-respiratoria ed a nulla possono le amorevoli cure del dottor Mannella inutilmente chiamato al capezzale del poeta, la cui corretta diagnosi fu di “scompenso cardiaco con idropericardio”.
"Morì quel piccolo corpo triste divenuto un nulla, ma un'eterna luce di consolazione da esso irradiò su la vita degli uomini"
Paolo Signore